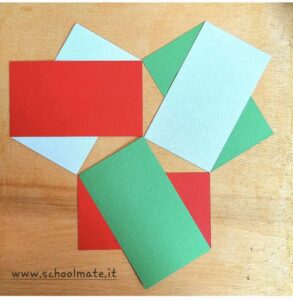Alcuni giorni fa un’insegnante della scuola che dirigevo a Nichelino, realtà allora particolarmente problematica dell’hinterland torinese, mi ricordava con un messaggio che più di una ventina di anni fa istituimmo nella scuola elementare un laboratorio di educazione all’affettività e alla sessualità, osservando, con una punta di ironia, come già allora fossimo all’avanguardia, anche senza il supporto degli influencer.
Influencer o meno l’avvio del laboratorio fu reso possibile grazie a quel poco di organico funzionale e di risorse aggiuntive (L 440/97) che accompagnò la prima attuazione dell’autonomia scolastica, voluta dall’allora ministro dell’istruzione, recentemente scomparso, Luigi Berlinguer.
Il laboratorio, così come lo stesso tentativo di dare vita a una vera, per quanto iniziale, autonomia, ebbe breve vita. Il ministro che, come non bastasse l’autonomia, si era messo in testa di riformare anche gli ordinamenti scolastici, sostanzialmente risalenti alla riforma Gentile, fu presto trafitto dal fuoco amico e costretto alle dimissioni.
Dal 2001, ministro Letizia Moratti, cominciarono gli anni delle vacche magre: tagli indiscriminati, di finanziaria in finanziaria, fino a praticamente dimezzare in poco più di un ventennio la quota di PIL destinata all’istruzione. Operazione, quest’ultima, in cui si distinse per accanimento e perseveranza la ministra Gelmini. Continua a leggere