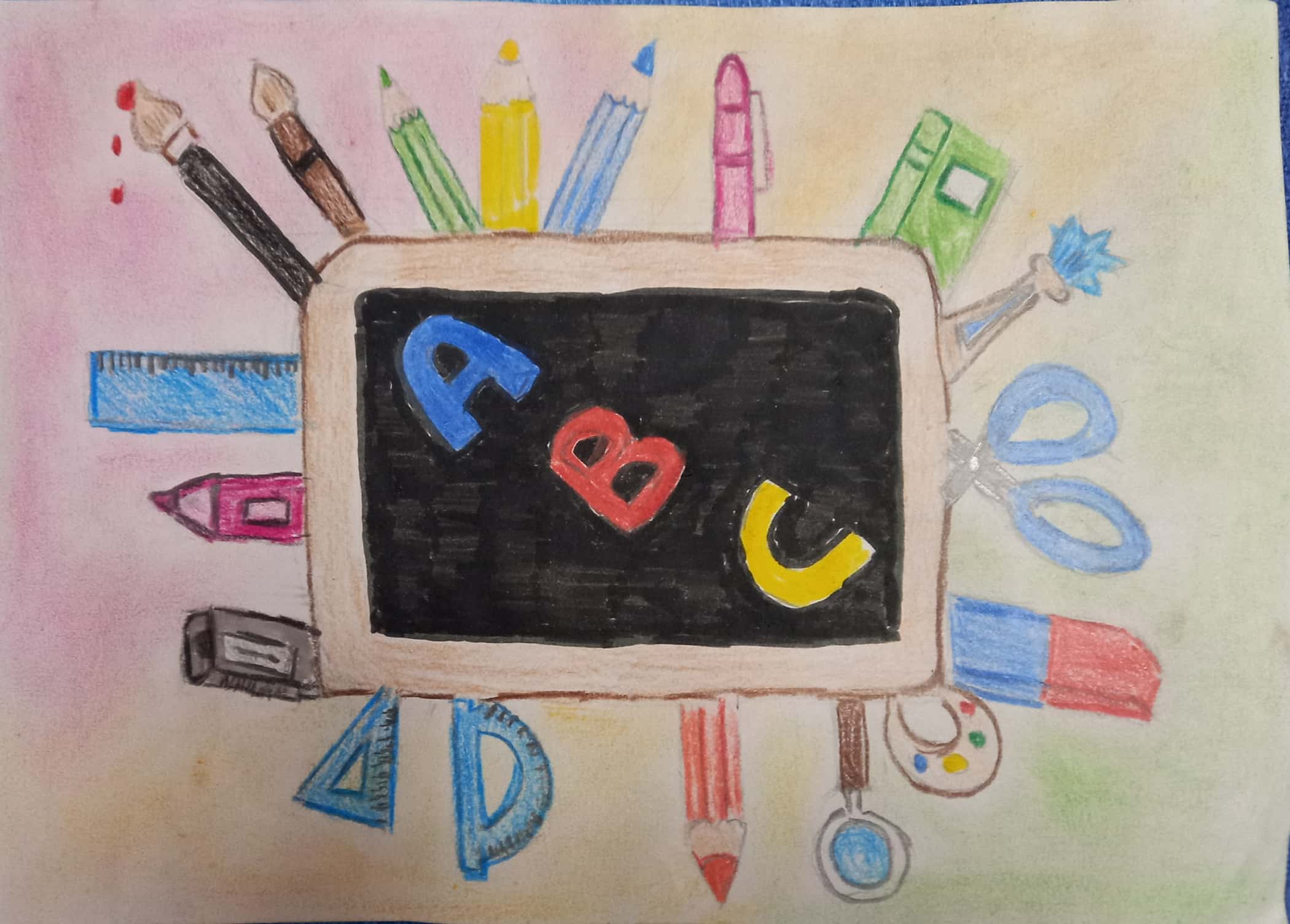Cattedra inclusiva: il profilo del docente specializzato ha mezzo secolo di vita
Lo scorso 25 gennaio è stato presentato, a cura dei suoi estensori (gli esperti Evelina Chiocca, Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Massimo Nutini, Nicola Striano) un “Progetto di legge per l’introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado”. Si tratta di un’iniziativa destinata ad avere, già nel suo primo impatto, una notevole risonanza per la natura e la rilevanza delle questioni di cui esplicitamente si occupa.
Io stessa, nel commentare un articolato e interessante intervento pubblicato su Facebook dal collega Pietro Calascibetta, auspicavo che fosse occasione per un approfondimento e un confronto aperto, per sviluppare quella cultura dell’inclusione di cui più che mai si sente il bisogno.
In quest’ottica si pone il contributo che oggi e qui intendo dare.
Ho letto con la dovuta attenzione il Progetto di legge, strutturato nella forma come una proposta destinata al dibattito parlamentare. Connotato che sottolineo per almeno due ragioni.
La prima è che un tema così rilevante deve sottrarsi a qualsiasi rischio di velleitarismo, e alla fin troppo abusata tendenza a “gettare un sasso nello stagno” per “vedere l’effetto che fa”, inevitabilmente esposta al fuoco di fila degli schieramenti opposti, che fanno aggio sui buoni argomenti.
La seconda è che la sede parlamentare, nei modi previsti, è il luogo istituzionale idoneo a dare forma a temi che riguardano i diritti e la loro esigibilità.
Il progetto di legge è anzitutto un’occasione preziosa, da non perdere, per riflettere e confrontarsi sul tema della disabilità nel sistema di istruzione ed educazione, e sulla cultura dell’inclusione che è più di una cornice: è lo sfondo che dà senso ad ogni intervento. Grazie davvero, dunque, a questo gruppo di colleghi che, venendo da diversi contesti e biografie professionali, si sono fatti carico di dare forma e sostanza ad una tappa importante del percorso verso una “compiuta inclusione”: con coraggio, onestà intellettuale, competenza e, non ultimo, passione attraversata dal vaglio dell’esperienza.
Fatte queste premesse, vorrei procedere con alcune considerazioni, possibilmente con la ragionevole sintesi che il luogo e il mezzo suggeriscono.
Parto, come uso fare in contesti anche di riflessione professionale, dalle fonti, che sono norme ma anche significati culturali che le animano. Vorrei soffermarmi sulla figura e la funzione del docente di sostegno, assumendo che il Progetto in parola non ne propugni la scomparsa (come qualcuno già sta paventando…) ma la rivisitazione.
Se è questo, come mi sembra plausibile, l’intento, bisogna prenderlo sul serio. Suggerisco a questo proposito di andarsi a rileggere il D.P.R. n. 970 del 31.10.1975, che individua i tratti essenziali del profilo dell’insegnante di sostegno, assegnato, dice la norma, “a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento.”
E’ mio il grassetto, con cui evidenzio passaggi a mio avviso rilevanti e pertinenti al tema. E’ appena il caso di sottolineare che la norma precede di circa due anni la L. 517 del 4 agosto 1977, che porta al livello ordinamentale il processo di integrazione nella Scuola di Base, superando le classi differenziali e le scuole speciali e introducendo appunto la figura dell’insegnante di sostegno all’integrazione.
Il criterio ispiratore delle due norme appena ricordate è in definitiva il superamento di ogni SEPARATEZZA come “trattamento educativo” della diversità e delle differenze. La prima “separatezza” da oltrepassare è (come spesso osservo negli incontri di formazione con i docenti) quella che si pone tra docenti comuni e docente di sostegno, emblema del trattamento separato destinato agli alunni disabili.
Superfluo, per gli interlocutori di questo mio intervento, sottolineare la variegata casistica delle pratiche invalse nelle scuole di ogni ordine e grado a conferma di questa tendenza. Diverso è, ovviamente, il diritto ad una didattica differenziata che è espressione del diritto all’istruzione e alla formazione di ogni alunn*. Ma qui il discrimine è sottile quanto decisivo: si differenzia PER integrare, nella prospettiva dell’inclusione. Per questo il docente di sostegno è, a tutti gli effetti, il docente della classe e nella classe.
Di qui, l’altro principio-cardine che caratterizza, fin dall’origine, l’esercizio della funzione del docente di sostegno: la CONTITOLARITA’ nel contesto del team dei docenti della classe.
E’ così sostanziale questo principio che dopo ben diciassette anni dalla L.517/77, le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Miur del 4/08/2009) lo richiamano, affermando tra l’altro:
“[…] il contenuto della Legge 517/77 che a differenza della L. 118/71, limitata all’affermazione del principio dell’inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero consiglio di classe e attraverso l’introduzione dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno“.
Anche in questo caso, il grassetto è una mia scelta grafica, per sottolineare un passaggio rilevante ai fini di questa disamina.
La cultura dell’inclusione è un processo aperto, che rifugge ugualmente dalle cristallizzazioni pregiudiziali e dalle “fughe in avanti”: per questo, avviandomi a una (molto provvisoria) conclusione di questa mia riflessione, mi sembra pertinente al tema e ai motivi ispiratori del Progetto di legge in parola richiamare brevemente l’idea di “sostegno diffuso”, da più parti sollevata, soprattutto a partire dall’inizio degli anni 2000. Anche qui, non mancano le insidie di interpretazioni fuorvianti e di atteggiamenti liquidatori. Per questo, mi sembra utile riportare un passo del testo “Il piano educativo individualizzato. Progetto di vita” a cura di D.Ianes e S. Cramerotti, ed. Erikson, 2007:
“Le attività dell’insegnante di sostegno dovrebbero estendersi e integrarsi in una più globale funzione di sostegno, attivata dalla comunità scolastica nel suo insieme, nei confronti delle tante e diverse situazioni di disagio e difficoltà che si manifestano. In questo caso sarà l’insieme della comunità-scuola, composta di insegnanti, personale tecnico, alunni e altre persone significative, che mobiliterà tutte le risorse disponibili, formali e informali, per soddisfare i bisogni formativi ed educativi speciali degli alunni, in relazione al tipo e al grado di difficoltà”.
E’ opportuno chiarire che una corretta interpretazione di queste affermazioni non deve significare, a mio avviso, il superamento (nel senso di soppressione) della figura e della funzione dell’insegnante di sostegno, quanto piuttosto sottolineare che la sua azione POSTULA come necessaria condizione la funzione inclusiva del CONTESTO.
Mi auguro che questa mia ricognizione sia un utile contributo al dibattito culturale, professionale, politico-istituzionale attorno ad un’iniziativa come quella del Progetto di legge appena annunciato. A me sembra, dagli elementi di riflessione proposti, che la prospettiva abbia dalla sua parte solide motivazioni, anche se non manca di nodi di criticità. Ne indico un paio che possono essere oggetto di discussione sia negli ambienti che si muovono attorno alla scuola e ai temi dell’educazione in chiave inclusiva, sia (non meno) in sede di un dibattito parlamentare che auspico possa essere l’approdo dell’iniziativa.
Il primo riguarda la modalità di attuazione del percorso e le procedure che vi sono collegate, alcune esplicitamente. Mentre considero un fatto positivo la previsione dell’attuazione graduale dell’innovazione (segno di saggio realismo) ho qualche perplessità sui modi prefigurati. Detto in termini espliciti, preferirei che gli incarichi orario (su posto di sostegno e, reciprocamente, su posto comune) ovviamente conferiti dal dirigente scolastico, nell’ambito delle prerogative attribuitegli dalle norme, siano formalizzati dopo una procedura che preveda il passaggio negli Organi Collegiali preposti alla programmazione educativo-didattica.
Non si tratta di un astratto omaggio al formalismo delle procedure, ma di una concreta cura della qualità democratica dell’istituzione scolastica. In questo caso specifico, mi sembra per di più che possa ben rappresentare a livello istituzionale quel principio di corresponsabilità educativa su cui mi sono soffermata suffragandolo con il riferimento alle norme.
Secondo rilievo: riguardo alle modalità, ho delle forti perplessità sulla previsione “a regime” dell’innovazione; qui i miei dubbi riguardano la sostanziale obbligatorietà dell’assunzione di incarico sulla cattedra “mista” (o “inclusiva”). Così vincolante che l’articolato prevede puntualmente i casi di deroga (legandoli in sostanza a fattori anagrafici). Capisco le esigenze di natura gestionale ed organizzativa che possono aver ispirato questo criterio. Ma mi domando, proprio perché si innesti un processo di tipo culturale e professionale, attento alla qualità dei percorsi oltre che alla efficienza dei risultati, se non sia preferibile evitare una “coscrizione obbligatoria”, nella prospettiva di coinvolgere la totalità della platea dei docenti. Non voglio entrare nei dettagli di eventuali dispositivi emendativi, in sede di discussione parlamentare, a questo riguardo, ma suggerirei di prevedere una prima fase di sperimentazione (ad esempio, triennale) che coinvolga i docenti come protagonisti attivi e consenzienti, e non come destinatari passivi: l’esperienza passata ci dice che questo può compromettere la buona riuscita della più illuminata delle riforme. Sarebbe un’occasione persa.
Mi fermo qui. Spero che il percorso attivato da questi colleghi (alcuni dei quali conosco personalmente, considerandoli preziosi interlocutori dell’educazione che ci sta a cuore) prosegua: con lungimiranza, come è nato, con il coraggio delle idee di cui c’è più che mai bisogno. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle ragazze, non perché lo “meritino” ma perché ne hanno il diritto.