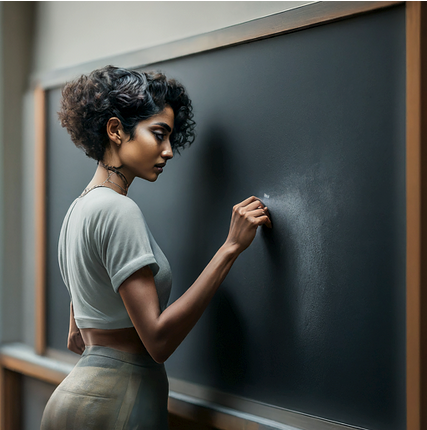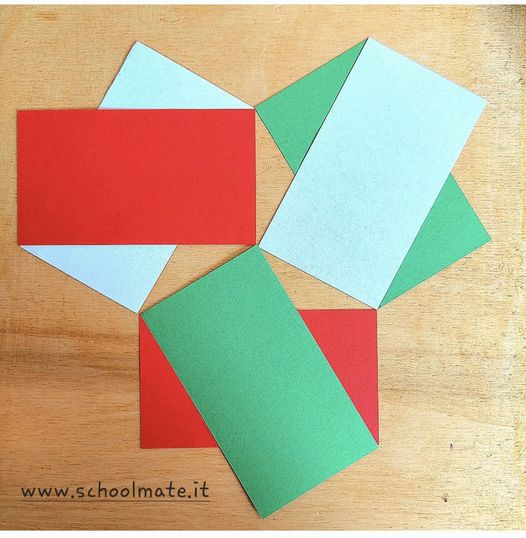Come succede da decenni, per tutti i fenomeni di moda e spinti dal marketing nel campo delle tecnologie (spesso non più o non ancora vendibili sul mercato), si vuole introdurre la IA nella scuola a livello di aggiornamento e promessa innovazione nel campo linguistico, della valutazione, della individualizzazione dell’insegnamento; il ministro di turno avvia iniezioni o sperimentazioni della tecnologia non più/ancora vendibile sul mercato. Per fortuna questa volta timidamente, non come la invasione delle LIM, delle piattaforme, cui ci siamo assuefatti in modo passivo ed anche per responsabilità del Ministero (ad es dalla DaD in poi). Intanto fioriscono e gareggiano corsi che ti spiegano a cosa potrebbero servirti, quali problemi potrebbero risolvere. Nella stabile confusione tra innovazione tecnologica e nuove idee e nuovi investimenti per risolvere i problemi. Nessuno vuol restare indietro, nessuno sa come risolvere i problemi. Ma la tecnologia non è come l’acqua santa: non basta immergervi la scuola per risolvere tutte le sue criticità.
La (o le IA), soprattutto i prodotti e servizi di intelligenza artificiale basta su machine learning, sono a mio avviso: Continua a leggere