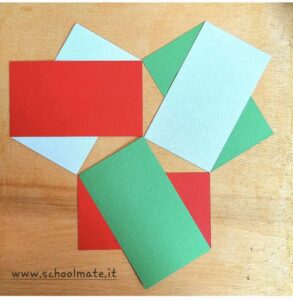Quando si incita ad affermare la propria identità, in sostanza si invita a sventolarla in faccia agli altri e questo certo non si può dire che sia un gesto di amicizia.
Pensare oggi di porre a coronamento del curricolo del primo ciclo di istruzione l’acquisizione della propria identità nazionale, come sembra nelle intenzioni dell’attuale ministro dell’Istruzione e del Merito, ispirato dal pensiero della coppia Galli della Loggia, Loredana Perla, rischia di mettere in serio pericolo l’impellente necessità di formare le nuove generazioni a viversi come cittadini di un mondo in cui difendere la convivenza comune e il proprio comune ambiente di vita. Significa non aver appreso la lezione della storia che è apprendimento della “grammatica della civiltà”, la propria e quella degli altri, per non ricadere nelle barbarie del passato.
Non ci sono distinguo che tengano, pretestuose denunce sull’ignoranza della storia e della geografia del proprio paese da parte di studenti e studentesse formati agli apprendimenti e alle competenze prescritte dalle attuali Indicazioni curricolari nazionali per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. Se tali carenze ci sono, le cause vanno ricercate altrove, non tanto perché non sia chiaro a cosa debba servire la scuola pubblica, ma, se mai, perché non è chiaro cosa e come la scuola pubblica debba essere.
Agitare l’identità come elemento di compattazione di un popolo nel terzo millennio del mondo dovrebbe rendere avvertiti dei pericoli che oggi comporta, rispetto ai vantaggi che si presume possano derivare. Continua a leggere