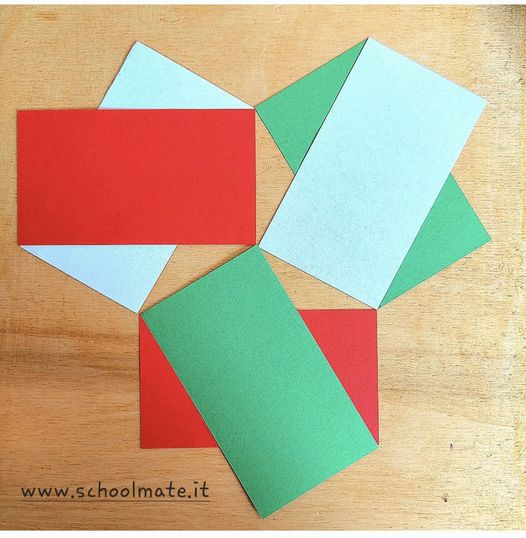di Luca Ballestra Caffaratti, Francesco Barbetta, Leslie Cameron Curry,
di Luca Ballestra Caffaratti, Francesco Barbetta, Leslie Cameron Curry,
Marco Guastavigna, Alessandro Monchietto, Alessandro Zanzo
NotebookLM è un dispositivo – al momento money free – di Google di cui qualcuno si sta finalmente accorgendo. Qualche mese fa era disponibile solo per gli accessi dagli USA, ma con una sana VPN lo si poteva provare anche senza uscire fisicamente dai patrii confini.
Su Gessetticolorati il primo accenno è di giugno 2024.
Nei mesi estivi è comparso qualche articolo, mentre per altro l’ambiente si arricchiva di qualche ulteriore funzione rispetto alla prima versione.
L’idea di fondo – ci pare – è quella di offrire un ambiente di assistenza alla presa (significativa) di appunti. In particolare, di fronte al rischio di sovraccarico informativo determinato dal proliferare di materiali (per ora testuali) in forme editoriali diverse, in particolare quelli rilasciati in open access, CCL e altre modalità aperte e che per altro consentono un possesso, una condivisione e un utilizzo pienamente congruenti con le modalità di elaborazione di NotebookLM.
Già, perché il dispositivo si fonda sulla sua capacità di “leggere” le “fonti” fornitegli a vario titolo dall’utente mediante la rete internet.
Queste possono essere file in pdf, txt, markdown, mp3, documenti e presentazioni di Google raggiungibili sul Drive di Alphabet, siti web e video di Youtube (intesi come trascrizioni dell’audio), testo copiato e incollato.
Nell’insieme, una ampia tipologia di materiali “testuali” su cui il dispositivo interverrà in varie forme, producendo output nella lingua più comoda per l’utente, indipendentemente da quella o quelle delle fonti stesse.
Il primo passo dell’elaborazione è la produzione automatica di un riepilogo e la proposta di tre domande esplorative.
NotebookLM eredita infatti il modello a perfezionamento conversazionale progressivo già proposto dalle prime chatbot, dove la produzione di ulteriori imbeccate dopo il primo “prompt” era a carico dell’utente, per poi essere incrementato in modo sempre più raffinato e coinvolgente mediante suggerimenti a carico del dispositivo, con lo scopo di arrivare al miglior esito possibile con la collaborazione tra agente artificiale e supervisore umano.
Questo approccio configura quindi una chat, ovvero uno spazio per approfondire – con una sorta di dialogo tra domande vere e proprie dell’utente e sollecitazioni del dispositivo – secondo un percorso non necessariamente lineare il contenuto delle fonti.
Le risposte alle domande, se giudicate interessanti e pregnanti, possono essere memorizzate per la seguente sessione di lavoro e perché siano utili anche ad altri utenti dello stesso blocco note.
NotebookLM utilizza infatti le modalità di condivisione tipiche del workspace di Google, che prevedono il possesso di credenziali specifiche della corporation, oltre a 18 anni di età minima.
Il vero e proprio blocco note propone al momento sei possibilità logico-operative strutturali:
- Sommario;
- FAQ;
- Documento di briefing;
- Guida allo studio;
- Sequenza temporale;
- Conversazione di approfondimento (attualmente a due voci e solo in inglese, ma facilmente traducibile con altri dispositivi di Intelligenza Artificiale).
 NotebookLM al lavoro sul regolamento europeo dell’IA
NotebookLM al lavoro sul regolamento europeo dell’IA
Abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro informale su questo dispositivo, perché vogliamo verificare se possiamo convertire la sua vocazione all’incremento dell’efficienza individuale o – al più – di team, tipico di chi deve affrontare su base competitiva la vastità del mercato della conoscenza e dell’istruzione, indirizzandola invece verso la crescita dell’emancipazione collettiva, volta allo sviluppo di capacità analitiche qualitativamente più arricchenti, perché costruite sul dialogo e sull’apertura, sulla cooperazione, sul mutualismo.
E sulla ulteriore condivisione di quanto elaborato: in primo luogo, questo contributo, che ci auguriamo non sia unico.
Per questa ragione strategica, elenchiamo e valutiamo gli utilizzi che abbiamo empiricamente messo in atto in questi mesi:
- Co-autorialità supervisionata in blog, dopo aver verificato l’attendibilità delle “letture” da parte di NotebookLM sottoponendogli materiali propri o ben posseduti concettualmente come test (Marco G.);
- “Filtro” per decidere se leggere o no un certo materiale Open Access o CCL (Marco G.);
- Richiesta provocatoria e traduzione automatizzata di Conversazioni di approfondimento per dimostrare la tesi che l’approccio dell’ambiente è l’aumento dell’engagement a qualsiasi costo e che pertanto viene trattato in questo modo anche il pensiero più radicalmente anticapitalistico (Marco G);
- Analisi strategica di documenti testuali non conosciuti, con richiesta di formulare elenchi costituiti da parole chiave e/o concetti significativi suddivisi per capitolo/paragrafo, con l’obiettivo di identificare elementi di interesse in documenti di medie e grandi dimensioni su cui effettuare approfondimenti e verifiche mirate (Alessandro M.);
- “Filtro” per aggiungere progressivamente altre fonti da fare analizzare al dispositivo sulla base dei presupposti indicati al punto precedente con l’obiettivo di operare confronti in termini di tematiche specifiche (Alessandro M.):
- Analisi strategica di documenti testuali di medie dimensioni, con richiesta di formulare confronti volti a identificare tematiche comuni e analogie tra diverse fonti già precedentemente verificate (Luca B. C.);
- “Filtro” per aggiungere progressivamente altre fonti da fare analizzare al dispositivo sulla base dei presupposti indicati al punto precedente con l’obiettivo di operare benchmark mirati tra più fonti (Luca B. C.);
- Richiesta di formulazione di report puntuali sulle attività di analisi strategica e benchmarking precedentemente descritte con l’obiettivo di ottenere resoconti costituiti da dati logicamente ordinati e consequenziali (Alessandro M. e Luca B.C.);
- Rielaborazione dei report tramite l’utilizzo di altri modelli di elaborazione linguistica per la realizzazione di testi di carattere discorsivo fondati sulle correlazioni e la consequenzialità individuate nei report (Alessandro M. e Luca B.C.).
- Sintesi di paragrafi di un saggio per avere a disposizione delle informazioni da riciclare in testi originali. (Francesco B.).
Ci proponiamo di esemplificare i vari usi a chi fosse interessato e contattasse la redazione di Gessetticolorati.it e di pubblicare per esteso i risultati più interessanti.