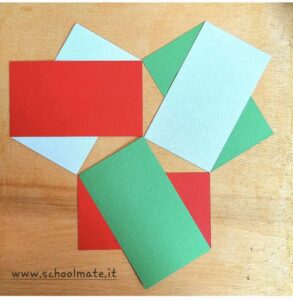“Controversia sullo storicismo tra Tilgher, Croce e Gentile” è un saggio di filosofia della storia, composto da Paolino Mongiardo nel 1968 per la sua tesi di laurea, conseguita nella facoltà di filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dopo un percorso di studi svolto sotto la guida di pensatori della statura di Ugo Spirito, Natalino Sapegno, Guido Calogero, Ettore Paratore.
“Controversia sullo storicismo tra Tilgher, Croce e Gentile” è un saggio di filosofia della storia, composto da Paolino Mongiardo nel 1968 per la sua tesi di laurea, conseguita nella facoltà di filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, dopo un percorso di studi svolto sotto la guida di pensatori della statura di Ugo Spirito, Natalino Sapegno, Guido Calogero, Ettore Paratore.
E’ una trattazione critica sul senso dello storicismo nelle due contrastanti posizioni di Croce e Gentile, da una parte, e il loro allievo Adriano Tilgher, dall’altra. Razionalisti, ottimisti e storicisti i primi due, dotati della serenità e freddezza necessaria ad evitare errori di valutazione, il terzo, istintivo, irrazionalista, antistoricista e pessimista fino al nichilismo. I primi due, dalla parola rasserenatrice, sostenitori di valori eterni che sempre trionfano e si affermano anche quando l’umanità si sente angosciata dalla mancanza di sicurezza e dalla sfiducia in quegli eterni valori, che vede perduti dinanzi alle distruzioni causate dalle due guerre mondiali.
Il significato pregnante di questo libro è da ravvisarsi nelle parole di Benedetto Croce nella parte conclusiva della trattazione: “E’ sull’istinto che trionfa la ragione inevitabilmente; è sempre sul male che trionfa il bene come un elemento susseguente della dialettica storicistica del mondo. E quando il bene trionfa di volta in volta sul male, la statura così dei singoli uomini come dei popoli si rinnovella e si fa più grande”.
In questa nuova riedizione del saggio, il prof. Mongiardo si propone di dimostrare che “anche quando l’umanità è angosciata dalla mancanza di sicurezza e dalla sfiducia verso valori eterni che sembrano andati perduti per sempre, come avvenuto all’epoca delle due guerre mondiali e come sempre avviene quando il senso della storia si fa tormentoso nei punti di crisi del divenire umano- afferma Mongiardo – sempre si eleva la parola rasserenatrice di Benedetto Croce, il filosofo dotato della serenità e freddezza necessarie ad evitare errori di valutazione, di contro agli istintivi e scalmanati irrazionalisti e nichilisti del tempo”. Continua a leggere