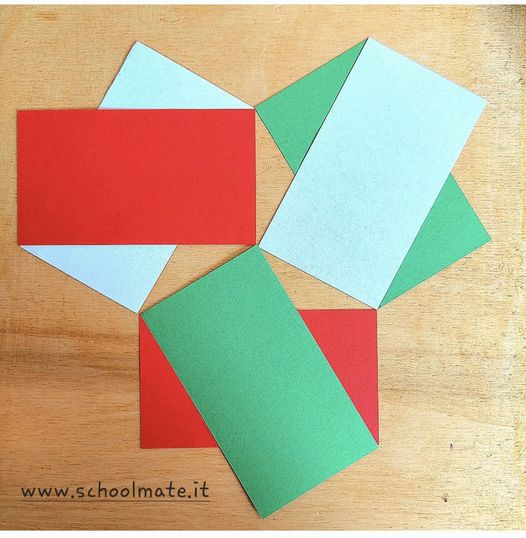Docenti, studentesse e studenti partecipanti al Torneo di Debate per Scuole secondarie di 1° grado Udine Liceo ‘Marinelli -giugno 2024, ’
di Annalisa Filipponi
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE COME MOTORE ORIENTATIVO
Il nuovo modello di certificazione delle competenze, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con decreto n° 14 il 30 gennaio 2024 apre ad una interessante possibilità per il Debate, che è quella di collegare i Tornei di Debate ai nuovi modelli valutativi, sempre nel rispetto dei criteri insiti nella struttura valutativa del WSD (World Schools Debating)[1].
Il modello certificativo ministeriale mette in evidenza il rapporto tra la Scuola secondaria di 1° grado e l’orientamento e, infatti, il decreto recita: “la certificazione descrive, ai fini dell’orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.”[2] Questo raccordo porta la certificazione delle competenze nel primo ciclo dell’istruzione ad essere un motore orientativo che ha come quadro di riferimento non i programmi ministeriali, ma il quadro europeo delle competenze[3].
Dal punto di vista del Debate lo schema del MIM evidenzia alcune competenze che sono la base strutturale di questa pratica didattico-formativa ormai da tutti riconosciuta come innovativa ed inclusiva. Citerei questi riferimenti, traendoli dalla scheda proposta dal MIM: Continua a leggere