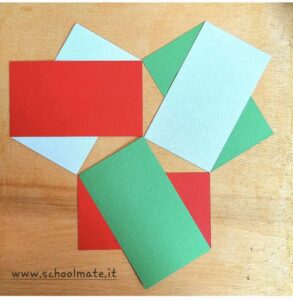di Aluisi Tosolini
Mettere mano agli indirizzi generali di un sistema educativo è sempre questione complessa che richiede moltissima attenzione e cura. Spesso si tratta, infatti, di dar corpo a documenti che segnano la cultura di un paese per decenni. E che per definizione vengono in genere affidati ad altissime e riconosciute personalità.
Per fare solo un esempio, pochi sanno che il concetto di post-moderno che ha segnato decenni della cultura contemporanea si deve all’opera di Jean-François Lyotard che nel 1979 pubblicò il volume La conditione postmoderne. Rapport sur le savoir che gli fu commissionato dal Canada in vista della revisione del proprio curricolo di studi. Lo stesso accadde con Edgar Morin e il volume I sette saperi necessari all’educazione del futuro, commissionato dall’Unesco.
Per questo quando in Italia sento parlare di “revisione delle indicazioni nazionali” mi vengono i sudori freddi, soprattutto se le persone di cui si parla come componenti del gruppo incaricato di procedere alla revisione non brillano certo per essere personalità di altissimo ed indiscusso livello intellettuale e culturale. Continua a leggere